
Giuseppe Berretta: uno scritto inedito su Martoglio ed il teatro dialettale siciliano
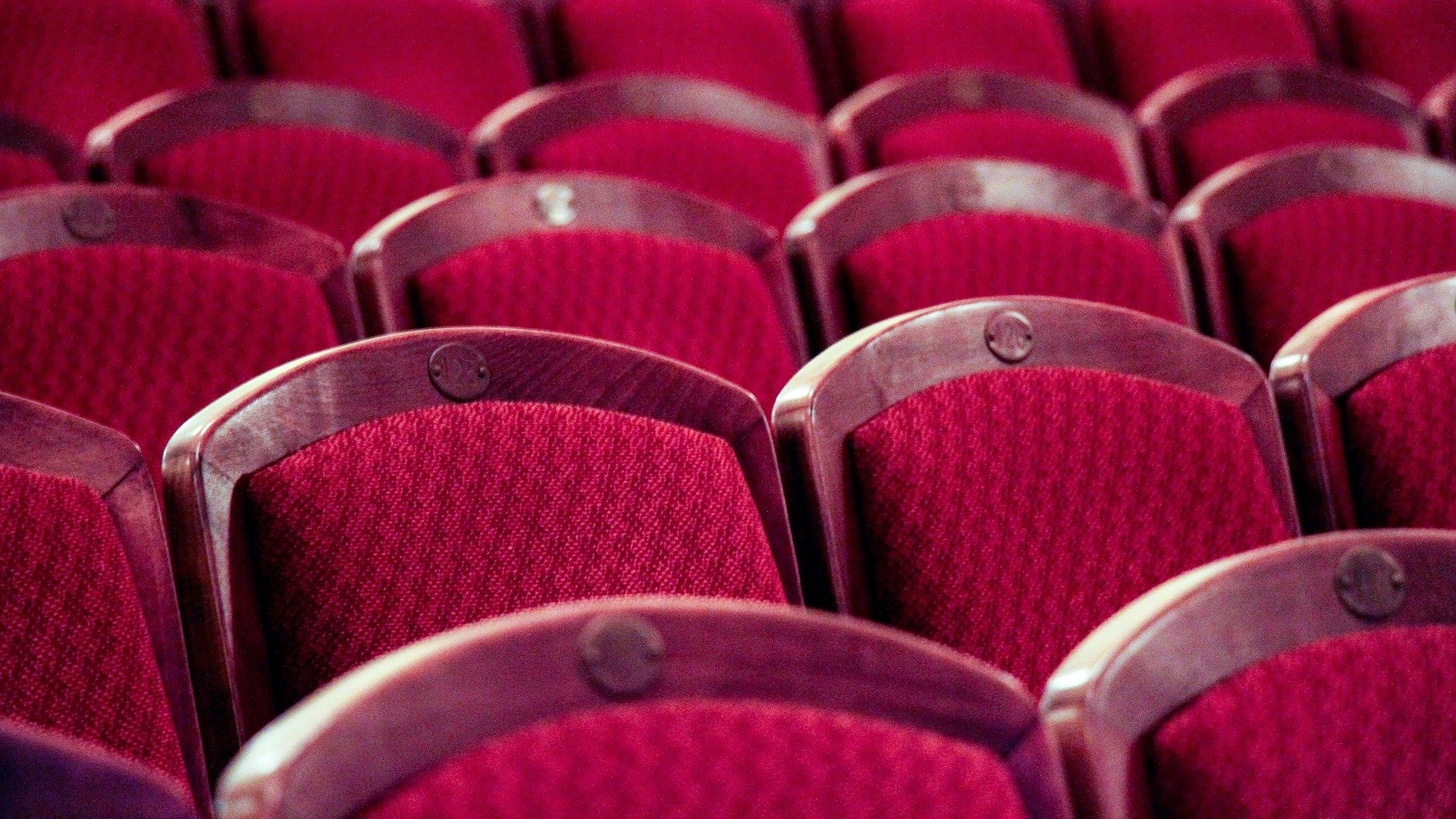
Nel numero 47/2014 della rivista Agorà, periodico di cultura siciliana, veniva pubblicato un mio articolo dal titolo: Ugo Saitta e Giuseppe Berretta, con il quale si metteva in evidenza il ruolo del professor Giuseppe Berretta quale diretto e principale collaboratore di Ugo Saitta e coautore per i soggetti e le sceneggiature del noto regista catanese. Giuseppe Berretta, inoltre, era sicuramente profondo conoscitore, oltre che di Dante di cui era apprezzato studioso, di Martoglio e del teatro dialettale siciliano. Grazie alla generosità della famiglia del defunto professor Berretta, abbiamo potuto recuperare una serie di lavori inediti i cui originali sono stati donati dalla sua famiglia alla biblioteca dell’Archivio di Stato di Catania ed una copia degli stessi alle Biblioteche Riunite Civica e Ursino Recupero di Catania. Il presente articolo riporta il testo di una conferenza tenuta da Giuseppe Berretta nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere dell’Università di Catania, in data 16 marzo 1973, a Palazzo San Giuliano organizzata dalla Società Dante Alighieri. La conferenza era stata annunciata sul quotidiano La Sicilia del medesimo giorno ed il giorno successivo, sullo stesso giornale, è stata l’oggetto di un positivo e dettagliato articolo, a firma G.F.C., nella “Cronaca di Catania”.
Ma lasciamo parlare l’autore; siamo dentro l’Aula Magna della Facoltà di Lettere e lo ascoltiamo:

Garibaldi si trova in America con Anita.
La scena rappresenta una foresta.
– Finalmente, mia cara sposa Anita, ci troviamo in questa foresta, per vedere se c’è qualche infelice che ha bisogno di aiuto, per così salvarlo.
– Sì, mio diletto sposo Garibaldi, perché tu, essendo chiamato il cavaliere dell’umanità, non devi far altro che aiutare i derelitti. Ma che sento? Ecco una lamento lontano!
– Sì, è una voce umana di donna. Presto, corriamo alla salvezza!
Cambia la scena e si vedono due pellirossa condurre una donzella.
– Vaja, arranca, arranca!
I pellirossa parlano in siciliano: lo stesso dialetto è sempre nell’opera dei pupi, espressione realistica di prosaicità e anche di malvagità. In dialetto parla non solo Peppenino, ma anche Gano di Magonza, in contrasto con il tentativo di italianizzazione aulica del siciliano che è nella parlata degli eroi. La donzella, spaventata, implora:
– Oh Dio! Voglio a mio padre, voglio a mia madre!
– Se vuoi a to padre e songo io, se vuoi a to matri è quello.
Questa volta il pellerossa cerca di italianizzare la sua parlata per farsi comprendere dalla donzella. Intervengono Garibaldi e Anita.
– Olà, a voi, mascalzoni, lasciate questa ragazza, se volete salva la vita!
– Chi dici? E tu chi mi rappresenti ? Compagno, ammazzamo a questo cretino!
– Ah sì? Anita!
– Garibaldi!
– Fuoco! (Pum, pum!)
– Ahi! ahi! Semu morti!
Ma Giovanni Grasso eleva l’ordine recitare ai suoi pupi Cavalleria Rusticana. In occasione di una di queste rappresentazioni Martoglio accompagnò al Teatro Machiavelli il grande tragico Ernesto Rossi, che incoraggiò il Grasso ad abbandonare definitivamente le marionette e a fare l’attore. E il Grasso rimise in scena Cavalleria Rusticana, non più con i pupi, ma in personaggi. Lo stesso Martoglio fissò in due sonetti che appaiono in Centona le impressioni di quella memorabile serata. Il dialogo si svolge fra due donne, di cui una popolana:
– È a Cavalleria Rusticana [...]
– Sissignura, accussì! [...] Chi cosa ranni!
– È un dramma ca fu scritti di Giuvanni [...]
– Giuvanni Grassu, ‘u sacciu! Vastiana u canusci; po’ aviri vintott’anni [...]
– Ma chi! [...] Giuvanni Virga! O Virga o nana [?] u fattu è ca mi vinni na quorana [??] ‘ntr’ò menzu ‘u cori! Vih, chi focu ‘ranni!
– Pirchì?
– Ci pari nenti parennu[?] chi ridu ci muzzica l’oricchia? [...] E dda gran schigghia: “Hannu ammazzatu a cumpari Turiddu! [...]” M’arrizzanu ‘i carni, vah! [...] E dda figghia di Santa, sventurata! [...] E chidda ‘e l’ova? Chi dramma naturali, malanova!


“Dui finestri ben guardati
Stannu aperti li jurnati.
Ma, vinennu, poi, la notti,
s’appuntiddunu li porti”
Sono, evidentemente, gli occhi. Ma i presenti non l’hanno capito e invitano lo zu Masi, che ha chiesto di partecipare al giuoco, di dare la risposta. Egli, appena gli ripetono l’indovinello esclama: “Haju caputu, va, non è cosa mia!” E, dinanzi all’imbarazzo, alla costernazione degli altri, dichiara:
“Chi vi criditi, ca mi sentu infelici? [...]
- No, affattu! [...] ‘nt’è primi, viditi, si [...] ‘nt’è primi mi parsi tuttu ‘u munnu finutu [...] ma poi a pocu a pocu vinni la rassegnazioni [...] mi trasiu ‘nt’ò cori comun a ducizza [...] chi sacciu, non v’u sacciu diri [...] ma ‘u fattu è chiddu ca m’hannu passatu cinc’anni comu fussiru cincu jorna [...] Quasi felici, va! [...] Nuatri orvi, amici mei, avemu certi soddisfazioni e certi piaciri, ca vuatri ccu ‘a vista mancu vi l’immaginati! [...] Chiddu di essiri prutetti di tutti, comu fussimu turnati picciriddi [...] chiddu di non vidiri tanti cosi laidi di ‘stu munnazzu tradituri”
Così, di colpo, all’allegria della scena precedente si sostituisce una intensa commozione, una atmosfera di tenerezza, la tensione di una situazione fragile, delicatissima, indifesa, che immediatamente fissano il personaggio e il tema centrale del dramma. In questo quadro di sentimenti e di emotività popolare che è, indubbiamente, anche, l’opera martogliana, la cecità è uno dei motivi di pietà maggiormente ricorrenti: basti pensare al personaggio di Miciu in Nica. Ma il motivo dominante di Scuru è l’intensità, l’assoluta dedizione dei sentimenti familiari, che è uno dei pilastri della scala di valori tradizionali siciliani. Zu Masi afferma di non soffrire della sua cecità perché vede attraverso gli occhi del figlio, in lui si specchia, nella sua laboriosità, nella sua stessa prestanza fisica. Egli, proclama, è la sua bandiera, è la vista degli occhi suoi. I figli, dal canto loro, vivono in funzione del padre e della sua infermità e Rosa sacrifica il suo amore per Decu per non abbandonare il padre e, poi, anche il fratello, divenuto, a sua volta, cieco di guerra. Decu, d’altra parte, anche se innamoratissimo di lei, accetta il suo sacrificio e compie il proprio rinunziando a lei, perché non vuole costringere la madre a vivere in quella casa tristissima. Così i sentimenti familiari diventano dei tabù sacri: a essi si deve dedizione assoluta, che non ammette compromessi, anche a costo di sacrificare irrazionalmente se stessi e gli altri. Ma il motivo più originale di Scuru è la solidarietà corale dei popolani che ne sono protagonisti, la fiducia e il rispetto reciproci, la semplicità antica dei loro svaghi. Nelle prime scene tutto il vicinato, vecchi e giovani, giocano agli indovinelli, poi improvvisano una rustica contradanza. E anche qui questa spontanea, gioiosa fedeltà alla tradizione trova la sua concretezza figurale nell’orchestra di carta velina, di pettine e di quartara con cui zu Masi e i suoi vecchi amici vogliono accompagnare, “all’usu anticu”, il ballo. Tutti vivono intensamente le vicende altrui in una solidarietà generosa e corale. La partenza di Nino per il fronte prima, poi l’annunzio festoso del suo ritorno, la dolorosa scoperta della sua sventura, il fermo proposito di nasconderla a zu Masi sono tutti vissuti con partecipazione unanime, sentita come “doviri d’amicizia e di vicinatu”.
“Signuri mei – proclama zu Paulu il più vecchio degli amici di zu Masi – chista è casa ca non si po’ lassiri un jornu sula, oh! [...] Un pocu per unu, tutti l’amici e vicini, nn’ avemu a sacrificare! [...]”. E una delle donne presenti: “Con tuttu lu cori, zu Paulu! [...] Si soli diri: carciri, malatii e nicissitati vi provanu lu cori di l’amici [...]”.
È, certamente, una struttura culturale primitiva, tradizionalista, conservatrice. E non mi riferisco tanto alla soggezione di questi popolani alle classi dominanti, alla accettazione, interamente rassegnata, della loro condizione e della loro incolmabilità delle differenze sociali, alla esaltazione del paternalismo autoritario con cui, in U Paliu, capitan Blanco esercita la sua funzione di sindaco, quanto a tutto ciò che si riferisce, per esempio, ai modelli dell’onore, dell’amore, dei rapporti sessuali. La verginità femminile è tradizionalmente, in questa sfera, uno dei tabù più qualificanti. L’iniziazione di una donna all’amore non è l’avvento di una nuova fase più matura, più piena di vita, una esperienza che può essere ricca di sviluppi anche spiritualmente fecondi, anzi è una conclusione, una fine, una caduta definitiva, al di là della quale non c’è che il disfacimento morale e anche fisico. Alla idealizzazione della fanciulla in quanto tale corrisponde un supremo disprezzo quando ella abbia conosciuto l’amore. Zu Masi, sempre, in Scuru, spiega alla figlia Rosa:
“Dimmi ‘na cosa: l’ha vistu mai, ‘n campagna, di bon matinu, ‘ddi fogghi d’arvulu, puliti puliti, chini d’acquazzina? [...] Dicu, figghia ‘na stizza di ‘ssa rugiata ca spicchia, a lu primu suli, supra ‘na fogghia pulita [...] Chi ti pari ? [...] A chi l’assimigghi? [...]”.
Risponde Rosa: “A un diamanti [...] A ‘na perla”.
Masi: “Ora ‘ssa stizza, ca pari ‘na perla, tu falla cadiri ‘n terra [...] Chi ti diventa?”
Rosa: “Fangu”.
Masi: “Biniditta la matri ca ti fici! [...] Ora, vidi, figghia mia, d’accussì è la femmina; [...] perla prima di cadiri, fangu doppu ch’è caduta”.
Nel dramma Nica Janu dice che ha voluto bene ad Angelina “Chiù di ‘na soru [...] chiù di Maria Santissima. E ‘ssu buttuneddu di Rosa mi pareva ca l’aveva a cògghiri iu, e mi lu scrisceva ccu l’occhi notti e jiornu”. E poi, alludendo al fugace incontro amoroso di Angelina con il seduttore don Luigino: “‘ssa Rosa si spampinau, senza ca ju nni sapissi nenti”. Per l’uomo cogliere la verginità di una donna, soprattutto se amata, è aspirazione suprema, comunque piacere inarrivabile. Ma il conseguente matrimonio è il pagamento di tale piacere, l’espiazione doverosa per quanto sgradevole, anche nel caso che entrambi ne riluttino, anche nel caso che esso non possa essere che fonte di infelicità. Janu ama, adora Angelina e tuttavia impone con le minacce, a Luigino, di sposarla, perché, come dice, la posizione sia regolata:
“Ju non vogghiu nenti. Ppi mia passau ‘a stati e vinni ‘u ‘nvernu, ‘nta ‘na vota vitti lu persicu appisu all’arvulu, jancu, russu e villutatu [...] lu criscivi ccu l’occhi [...] ‘na bedda matina truvavi l’ossu spurpatu! Pacenzia! Ma cu si mangiau ‘a purpa s’ha mangiari puru l’ossu, vasinnò si perdi ‘u nomu di Janu Carrà!”.
Su situazioni simili, o riconducibili al medesimo schema di valori, sono imperniati gli altri lavori drammatici, da Voculanzicula a Taddarita, a Riutura. E il carattere conservatore di questo mondo permane anche quando il Martoglio adotta i toni, per lui più congeniali, dell’umorismo e della franca comicità, come in San Giuvanni Decollatu o ne L’aria del continente. Il “Continente” e tutto ciò che da esso proviene sono guardati da questa società ora con stupore, ammirazione, complesso di inferiorità, ora con diffidenza, sospetto, disapprovazione morale. La verità è che, nell’immaginazione del siciliano – almeno fino a qualche decennio fa –, in realtà il continente era un mito, la proiezione delle sue frustrazioni e delle sue repressioni. La indeterminatezza stessa della indicazione, il Continente, contribuisce ad allontanarlo smisuratamente e nella dimensione geografica e nella dimensione umana. Alla lievitazione del mito contribuisce la coscienza inquieta, fatta di segreta vergogna e di ombrosa suscettibilità, che il siciliano ha della propria inferiorità sociale sul piano della cultura, dell’efficienza, dell’igiene. A fronte della risibile scienza di don Marianu Birritta, il medico condotto, l’ordine, l’organizzazione, la sicurezza dei medici e delle cliniche di Roma attingono, nella rievocazione del protagonista della commedia, i vertici della perfezione e della infallibilità. Fra le sue abitudini nuove, di cui don Cola Duscio si vanta come di una liberazione, ampio posto hanno i bagni, le docce, i massaggi, la cura e l’eleganza fisica e del vestire. Sono tutte cose che la cultura siciliana tradizionale ritiene superflue e frivole in confronto alla serietà, alla concreta responsabilità della vita che può e deve appagarsi, per esempio, quando si tratta di gente seria e posata, di indumenti semplici e funzionali come lo scialle o la scuzzetta. Don Cola ora rifiuta decisamente la scuzzetta, anche se si affretta a chiudere tutte le finestre per non “arrifridarsi”; il cognato lo prende in giro per questo, ma presto si toglierà anch’egli il berretto, lo nasconderà e, nel terz’atto farà a gara con don Cola per eleganza all’uso continentale: quelle sciccherie sono i simboli liberatori di una vita più ariosa, più indulgente, meno severa e, soprattutto, meno repressiva. Carattere liberatorio ha anche la libertà di parola:
“E lassativi parrari, lassatici sciogghiri lo scilinguagnolo alle ragazze, sveltitele, scaltritele, in modo ca quannu si maritano poi, sannu chiddu c’hannu a fari! [...]”.
Liberazione dalle ipocrisie, dalle inibizioni, dal senso oscuro di colpa che non solo impediscono alle ragazze di ascoltare in pubblico quello che già fanno, ma che indicano come scandaloso fare apertamente ciò che gli altri fanno nascostamente nel complice e pudico silenzio generale, che è socialmente riprovevole violare, come ora fa – finalmente! – don Cola Duscio. Ma è – soprattutto -, il Continente, nella dilatazione immaginaria della spregiudicatezza dei costumi, la dimora ideale della liberazione dalle inibizioni, dalle repressioni, dai tabù sessuali. Simboli sono ora le donne, affascinanti, eleganti, seduttrici, sempre disponibili. Ma, appunto perché liberazione degli istinti, reazione al secolare senso di colpa, ribellione alla moralistica regressività sociale, evasione dalla serietà e dalla responsabilità della vita, il vagheggiamento del mito assume i colori del rimorso e del peccato e i suoi simboli, le donne, tornano alla atavica identificazione col peccato: sono subdole, ingannatrici, da guardare con diffidenza e sospetto, diverse dalle vere donne. Don Cola Duscio è traumatizzato non tanto dalla notizia dei tradimenti di Milla, quanto dall’informazione che è una siciliana: fosse stata continentale, fatto normale, il suo onore sarebbe rimasto estraneo; ma è una siciliana, egli deve lavare l’onta, deve compromettersi. E rinunzia alla vendetta solo quando il delegato e la sorella gli hanno promesso che non diranno a nessuno che Milla è di Caropepe. Ma il rimorso del continente opera in don Cola già dal primo atto, malgrado la sua sicurezza, il suo ostentato disprezzo per tutto ciò che è siciliano. Egli già si sente in colpa, invoca appoggio e comprensione dai suoi stessi familiari, si aggrappa alla fine disperatamente a una spiegazione, a un alibi morale che lo giustifichi a sé e a loro. È stata l’operazione, che lo ha cambiato, totalmente. Sull’operazione egli insiste quando si scopre che egli è tornato da Roma con Milla.
“Mi vutaru dintra e fora, capiti? [...] Mi vutaru sutta e supira [...]”.
L’operazione è stata responsabile di quel rivolgimento, anche mentale, che egli incosciamente sente come un tradimento. Ma l’operazione, purtroppo, era necessaria: “Perciò – egli ripete – era megghiu ca mureva? [...] A ‘st’ura fussi mortu!”. Questo è il significato della scena, resa soprattutto famosa da Musco, in cui egli, nel finale del primo atto, scoperti tutti gli altarini, dinanzi alla indignazione della sorella e del cognato, rievoca a lungo, con i gesti, l’operazione, ne mima i momenti più emozionanti e drammatici e conclude, quasi con malinconia:
“E ora lassatimi viviri a modu miu! [...]”.
E non per nulla, quando nelle ultime battute della commedia egli si sarà liberato di Milla, quando avrà ripreso in mano il marruggio, in testa la scuzzetta e in bocca la pipa di coccio, quando si sarà, cioè, liberato dal mito e avrà riacquistato la sua sicilianità, cioè la norma e la costrizione contro la libertà dell’immaginazione e dei sensi, gli tornerà immediatamente l’attacco di appendicite. E tuttavia il ritorno alle origini sarà sentito dal protagonista, e quindi dal suo autore, ma, soprattutto, dal pubblico, come un riscatto, sarà sentito, a sua volta, come una liberazione da un comportamento alienante, da un complesso di inferiorità, per la riaffermazione della solidità di un sistema di valori e della validità di una cultura. Don Cola smetterà improvvisamente il suo artificioso tradurre in lingua dal siciliano, il suo parlare per frasi fatte, il suo sfoggio di interiezioni romanzesche (managgia a li cani, a li pescetti) e tornerà alla autenticità del dialetto. E, dinanzi alla prospettiva di una nuova operazione, ora, “si m’hannu a spaccari n’atra vota, mi fazzu spaccari cca, [...] Mi fazzu spaccari cca! [...]”. Struttura culturale, dunque, come appare da questi saggi frettolosi, tradizionale e conservatrive, ma che rispecchiava una precisa realtà ambientale, di cui ancora sopravvivono, persistenti, le tracce. Da questa fedeltà il teatro siciliano, nella forma martogliana, ha ricavato una validità che dura ormai da tre quarti di secolo. Oggi, certo, quella struttura culturale è in crisi, quei contenuti in via di superamento, altre sono la problematica e la sensibilità dell’ambiente siciliano, diversi i drammi e i miti. Ma l’aspirazione del Martoglio a un’arte in continua, vivente, scambievole osmosi con la realtà storica e ambientale del proprio tempo, colta nella più immediata genuinità del sistema di miti popolari, e la sua indicazione del teatro come il canale più vitale di tale comunicazione sono valide più che mai. E, chiusa la stagione degli spericolati sperimentalismi, potrebbe essere anche una via di salvezza – che già Gramsci preconizzava – del teatro stesso».
Fotografia di copertina: Pixabay
Immagini all'interno dell'articolo:
Giuseppe Berretta ritratto insieme al regista catanese Ugo Saitta
Nino Martoglio (Fonte: Wikipedia)
Giovanni Grasso e Virginia Balistrieri nel film Sperduti nel buio (1914) (Fonte: Wikipedia)
N.B. Il testo riportato in questo articolo proviene da un documento manoscritto che, finora inedito e redatto da Giuseppe Berretta esclusivamente per la conferenza del 16 marzo 1973, non era stato all’epoca revisionato ai fini di una pubblicazione. Pertanto, pur consapevoli di alcune piccole imperfezioni in esso contenute (imperfezioni che comunque non ne pregiudicano la comprensione), abbiamo preferito non apportare alcuna correzione.
clicca e scopri come sostenerci
Autore
Autore

Santi Maria Randazzo vive a Motta Santa Anastasia. Nel 1975 si è laureato in Pedagogia presso l’Istituto Universitario di Magistero di Catania con una tesi sulla delinquenza minorile.
Dopo avere svolto per tre anni attività di assistente volontario presso la Cattedra di Teoria e Storia della Didattica presso l’Istituto Universitario di Magistero di Catania, l’Amministrazione Provinciale di Catania gli ha conferito l’incarico di svolgere una indagine sulla devianza giovanile. Dal 1978 ha lavorato presso i Servizi Sociali del Comune di Catania, prima con il ruolo di Assistente Sociale, poi con quello di Funzionario-Coordinatore di Centro Sociale. Su incarico del Comune di Catania ha collaborato con la Procura per i Minorenni presso il Tribunale per i Minorenni di Catania e con il Provveditorato agli Studi di Catania. Per diversi anni ha fatto parte del Comitato Provinciale per la Prevenzione delle Tossicodipendenze, del Consiglio Scolastico Provinciale e dell’Osservatorio Permanente sulle Problematiche dell’Età Minorile istituito presso l’ex Provveditorato agli Studi di Catania e per conto dello stesso Organismo ha svolto indagini sul lavoro nero minorile in Provincia di Catania.
In passato ha ricoperto ruoli dirigenziali in ambito associativo, sindacale e politico, è stato capo delegazione CGIL-CISL-UIL al Comune di Catania. È stato corrispondente da Motta per il giornale La Sicilia. Da quando è andato in pensione, si dedica con passione allo studio della storia della Sicilia, trascorrendo gran parte del suo tempo presso le più importanti biblioteche dell’Isola. Ha pubblicato due libri in digitale, Motta Santa Anastasia nell’antichità: uno degli ultimi misteri della storia siciliana (2012) e Storia di Motta Santa Anastasia. Dalle antiche origini fino alla prima metà del XV secolo (2013), e per Algra Editore il volume Il ritorno degli Aragonesi in Sicilia (2019). Ha collaborato con diverse riviste: ArcheoMedia, Agorà, Incontri, Sicilia Report, Sikelian e MetroCT. Ama lo sport ed in passato ha praticato rugby e atletica leggera.







